

Umberto Eco considerava il fumetto la nona arte. Appassionato e collezionista, qualche tempo addietro affermò: “Quando ho voglia di rilassarmi leggo un saggio di Engels, se invece desidero impegnarmi leggo Corto Maltese.”
Ecco, sfatiamo un mito – il fumetto è per tutti! Non più considerato un genere poco adatto agli adulti, intere generazioni si sono appassionate a questo mondo, trovando in esso uno strumento per evadere, per sognare, per partecipare alle avventure e alle disavventure di vari personaggi, frutto della fantasia e della matita di grandi illustratori. Come per esempio nel caso dello statunitense Charles M. Schulz (1922-2000), autore della striscia a fumetti più conosciuta del mondo, ovvero i Peanuts che racconta le frustrazioni, le ansie, le illusioni e le speranze di alcuni personaggi bambini, in cui tantissimi di noi riescono a rispecchiarsi.
Uno di questi personaggi presta il nome al periodico linus – la prima rivista di fumetti pubblicata in Italia nell’aprile del 1965, sotto la guida del suo fondatore e inventore, Giovanni Gandini (ne rimarrà direttore fino al 1971). Si racconta che lo stesso Eco avrebbe voluto pubblicare in anteprima per i lettori italiani le storie dei Peanuts, però ahimè per lui, fu preceduto di poco da Gandini. Quest’ultimo decise di intitolare la rivista come l’omonimo personaggio della striscia di Schulz, in quanto “un personaggio pieno di fantasia, è simpatico e ha un nome facile da dire e da ricordare”. Allo stesso tempo, sempre secondo Eco, incarna tutte le nevrosi degli adulti, pur rivelando anche improvvisamente abilità fantascientifiche e maestrie vertiginose.

Sulla copertina del primo numero, essenziale ed elegante, è raffigurato su uno sfondo verde Linus (amico di Charlie Brown) insieme alla sua inseparabile, oramai celeberrima, coperta, diventata nell’immaginario collettivo sinonimo di sicurezza e protezione. Tra le pagine di questo primo mensile, oltre alle storie di Charlie Brown, c’era un episodio completo di Braccio di Ferro, nonché un’intervista di Umberto Eco a Elio Vittorini e Oreste del Buono (che prenderà le redini della rivista dopo Gandini e ne sarà direttore per quasi 18 anni, in due stagioni diverse del mensile), che costituì le prime basi delle nuove teorie sul fumetto.
La rivista linus vanta all’attivo 700 numeri, attualmente raggruppati ed esposti in un unico, eccezionale spazio all’interno del Castello Estense, nello specifico nella Sala dei Comuni. La mostra portata a Ferrara da Marcello Garofalo ed Elisabetta Sgarbi, in collaborazione con Igort, racconta la storia d’Italia e dei grandi illustratori: è una mappatura delle personalità del passato e del presente che hanno lasciato e che lasceranno un segno nella nostra cultura. In qualche modo la rivista potrebbe essere considerata una linea del tempo, che narra e illustra eventi, personaggi, fatti storici che hanno accompagnato i nostri nonni, i nostri genitori e che continuano ad accompagnare pure l’attuale generazione. La carrellata delle copertine esposte è una visione straordinaria di colori e nomi.
Tra i vari illustratori che hanno contribuito a rendere linus quasi un’icona si possono elencare: Guido Crepax, Altan, Andrea Pazienza, Hugo Pratt e Zerocalcare, mentre alcune copertine sono dei segni semiotici incontrastabili e raffigurano in alcuni casi personaggi come Battiato, Pasolini, Bassani. Nel numero di settembre del 2019 ha fatto capolino tra le pagine del mensile anche un nostro concittadino, l’artista Marcello Carrà, per raccontare il suo libro La sindrome del pallone, edito come linus da La nave di Teseo.
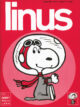
Igort, direttore della rivista dal 2018, ha dichiarato che alla base della mostra c’è un’idea pop, proprio in quanto la stessa arte del fumetto è un’arte riprodotta, le stesse copertine di linus sono oggetto di riproduzione. Tale associazione è più che azzeccata, non soltanto per il concetto di riproduzione, ma pensiamo anche soltanto alle opere dell’artista americano Roy Lichtenstein (1923-1997) che attingeva al mondo dei fumetti per la sua arte.
linus ha contribuito a mutare l’opinione pubblica italiana sul fumetto, considerato ai suoi albori “come un sottoprodotto della cultura americana” e a rinnovare la sfera della comunicazione, contribuendo alla conoscenza e alla letteratura (e lettura) di massa. Il fumetto è un linguaggio a sé stante, strutturato e codificato, in grado di dialogare con gli altri linguaggi. Può risultare popolare o di nicchia, ciò che è certo, è che da oggetto scarsamente considerato si è tramutato in oggetto da collezionare e perché no, a volte da mettere sotto una teca.
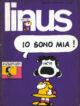
INFO
Linus. Tutti i numeri dal 1965 al 2023
Castello Estense, Sala dei Comuni
8 settembre – 26 dicembre 2023
A cura di Marcello Garofalo, Elisabetta Sgarbi, in collaborazione con Igort
Mostra organizzata da Comune di Ferrara, Fondazione Ferrara Arte, Fondazione Elisabetta Sgarbi, La nave di Teseo, Baldini+Castoldi
Orari di apertura: dalle 10:00 alle 18:00, chiuso il martedì






























