

Sabato mattina al tavolino di un bar, davanti a un caffè. Marco Gulinelli ha sulle ginocchia un notes pieno di appunti manoscritti, quasi fosse lui l’intervistatore. D’altronde, la prima tappa di ogni processo di scrittura è appunto prendere nota dei propri pensieri e delle proprie fantasie.
Al di là della vetrata il primo sole sfacciato di primavera e la sagoma del Castello estense. “Bella Ferrara, eh?! La bellezza è di tutti, da lei dobbiamo ripartire”. Affermazione che sa di slogan elettorale. Non a caso Marco è candidato alle prossime elezioni amministrative. “Ecco – anticipa le mie parole Gulinelli, quasi scomodo sulla sedia – affrontiamo subito quest’argomento, così ci togliamo il pensiero e poi possiamo parlare di cose serie!”.
Ma chi te l’ha fatto fare?
“Mi è stato chiesto per stima, ho risposto per stima. Sul piano teorico mi riconosco pienamente in un movimento che ha sostituito il principio di identità politica con quello, molto più inclusivo, del valore della bellezza. Chi ha amministrato la città ha fatto cose pregevoli, ma con il tempo si è cristallizzata una unica idea dominante di fare cultura, mentre invece la cultura è proprio l’espressione di prospettive e idee diverse che devono interagire. Mi piacerebbe tirare fuori faville che sono rimaste silenti nei cassetti, ricominciare a scovare talenti, guardare a realtà artistiche alternative. Certo, le logiche della politica e alcuni toni non sono i miei; io certo di affrontare ogni cosa con tenuità. Speriamo di non venire stritolati da questa esperienza”.

Cosa fatta, capo ha. Ora sotto con le cose serie! Sì perché la borsa degli attrezzi di Marco Gulinelli è colma di personalità poliedriche e maschere diverse. Molte improbabili, e tutte credibili. Passioni che non diventano professioni, ma che vengono alimentate con professionalità. Dal calcio alla fotografia; dalla musica alla letteratura. Un libero professionista che dopo aver scollinato i 50 si scopre scrittore di successo, grazie anche all’intuizione di Elisabetta Sgarbi e dell’editing staff de La Nave di Teseo.
Dunque c’è un’anima da romanziere dentro ogni geometra?
Ringrazierò sempre Elisabetta Sgarbi ed Eugenio Lio per l’occasione datami. Per risponderti citerei Primo Levi, uno dei più grandi scrittori del Novecento che nella vita, tra le altre cose, ha fatto anche il chimico, e che diceva che dentro ognuno di noi ci sono varie anime; apparentemente in contraddizione tra loro, ma in fondo ognuna alimenta le altre. Senza il mio mestiere fatto di misurazioni e lotte quotidiane contro la burocrazia non sarei mai riuscito a percepire la quotidianità delle persone e delle cose. Fare il geometra, l’attività forse più antiletteraria che ci sia, mi ha regalato un fenomenale strumento letterario: come una lente d’ingrandimento per osservare la realtà.
C’è molto di questa prospettiva di metodo nel tuo esordio letterario, la raccolta di racconti La perizia; con quella parola che significava al tempo stesso il risultato del lavoro quotidiano del narratore, ma anche l’attitudine a guardare le cose con occhio attento…
Proprio così. Tutto il libro era costruito su un sottile filo rosso che legava vocaboli dal doppio significato. Oltre alla perizia, anche il concetto di bene assumeva una doppia valenza a seconda del mondo a cui si riferiva. Per quello materiale era il bene immobile da periziare; per quello immateriale era il valore supremo della vita di comunità.
Un po’ Primo Levi, ma anche un po’ Ludovico Ariosto, che si divideva tra la arida vita del funzionario di corte e lo sconfinato galoppio della sua creatività letteraria. Due mondi così difficili da far convivere nell’agenda giornaliera?
La mia giornata tipo è una confusione totale. Ho smesso di credere di poter dettare le regole del gioco, mentre è vero piuttosto che le subisco. Spesso mentre sono in situazioni di lavoro, da un cliente, o meglio ancora in macchina mentre vado su un cantiere, ho la necessità di appuntarmi delle cose, perché altrimenti le perdo; spunti, idee, semplici sensazioni che manipolerò in seguito. Allora mi fermo sul ciglio della strada e scrivo, o registro. La macchina, in generale, è una grande generatrice di idee. Una cosa che mi porto dietro da quando ero bambino: durante i viaggi io e mio padre facevamo il ‘gioco del perdersi’, e ci inventavamo storie alternative alla realtà. Quello stimolo mi è rimasto.
Ti sei mai perso realmente?
Una volta, ed è stata una delle giornate più importanti della mia vita. Ero a Chicago, il gruppo di amici chissà dove, pioveva a dirotto; intirizzito e avvilito entrai in un locale dall’aspetto poco raccomandabile per proteggermi e raccogliere le idee. Dentro: un grande bancone e musicisti che suonavano blues. Ad un certo punto salì sul palco una signora di colore un po’ in carne intonando “I’m a Woman”, da quel momento partì la magia e mi persi sul serio. Non lo sapevo, quella donna era Koko Taylor. È stata la mia epifania per la musica.
Da lì il jazz, Springsteen e cos’altro?
Il jazz all’inizio non lo capivo, ma le mie orecchie sapevano già tutto prima di me. Il Boss è stata più una forma di condivisione con un gruppo di amici, e una reazione a Bob Dylan: c’è stato un tempo nel quale, per dire cose scomode, c’era bisogno anche di alzare il volume. Oggi invece ho riscoperto tutto il fascino della voce non musicale di Dylan, e d’altro lato quando scrivo sono ossessionato dalla musicalità della parola. Tra l’altro anche la passione per la fotografia ha a che fare con la musica…
Un’altra epifania?
In un certo senso sì. Tutto è iniziato dal desiderio di emulare un amico, Maurizio Cavallari, grande fotografo di concerti e grande giocatore di calcio. Il battesimo del fuoco è stato con i Rolling Stones, la sera dopo la vittoria ai mondiali del 1982. Scatti ‘rubati’ in mezzo alla folla, non nella comodità della press area. Fotografare un jazzista è una sorta di lavoro artistico; con Jagger, o anche Springsteen, è tutto più complicato, devi cogliere l’attimo in un continuo movimento. Tra l’altro a quei tempi non c’era il digitale: se lo scatto era buono lo scoprivi dopo 10 giorni.
Foto di Marco Gulinelli
Altri concerti “segnanti”?
Quello di Stevie Ray Vaughan a Pistoia Blues: lo guardavo quasi senza scattare fotografie, colpito dalle magie che scaturivano dalla sua Fender Statocaster, anche lui quella sera pareva essere in un altro luogo, suonò aprendo gli occhi pochissimo. Una settimana dopo ebbe un incidente fatale precipitando con un elicottero, e si trattò di una tragica coincidenza perché quel volo doveva trasportare non lui ma bensì Eric Clapton. Mi porto dentro il suo blues come un inno alla vita. Ma devo citare anche Enzo Jannacci a Ferrara, nel cortile del Castello. Prima del concerto gli chiesi se avessi potuto fotografarlo, lui acconsentì ma poi mi prese in mezzo per tutta la serata. Mi diceva: ‘fammi capire, sei geometra e fai il fotografo?’. Gli risposi ‘anche tu sei medico e fai il cantante!’.
E qui torniamo alla moltiplicazione delle personalità. Quando hai deciso che non scrivevi più per te stesso, ma scrivevi per essere letto?
“Anni fa ho vissuto un periodo professionalmente difficile, e scrivere mi sembrava l’unico antidoto per non esplodere. Poi, poco alla volta, è spuntato l’ego. Essere letto diventava una forma di riscatto, mi dava l’opportunità di vestire una maschera diversa rispetto all’immagine che molti avevano di me. E ho scritto fondamentalmente dei miei demoni. Con Il trapezista ho chiuso un cerchio: ho fatto i conti conclusivi con i miei ricordi e ho capito di poter avere diritto di cittadinanza nel mondo della letteratura”.
Prossimi progetti?
“Sembra ridicolo a dirsi, ma sto lavorando a un romanzo western che è il frutto di spunti molto diversi che si sono incontrati: la notizia del soggiorno a Ferrara di Buffalo Bill a inizio ‘900, uno strano sogno che ho fatto, una canzone di De Gregori, la musica di Ennio Morricone, i film di John Ford e di Sergio Leone. Sarà un libro sull’inutilità della vendetta”.
Mi pare che il gioco del perdersi continui…
“Anche se spesso la realtà supera la fantasia. Il gioco del perdersi è il grande insegnamento di metodo che mi ha lasciato mio padre; per il resto, mi sono sempre fatto appassionare da tutto ciò che non piaceva a lui. Lui uomo pragmatico, con i piedi per terra; io interessato a tutto ciò che è immateriale. Continuava a dirmi che mi voleva geometra, perché i numeri non mentono. Io il geometra l’ho fatto, ma a modo mio…”.
Classe ‘74, quando Cruijff e l’Olanda deliziavano il mondo senza vincere (che è ancora meglio), pesci ascendente gemelli (dicono). Una quasi laurea in architettura (3 esami, ma brillanti), una laurea in lettere, un dottorato in storia. Oggi è variamente ricercatore, insegnante, pubblicitario, libero pensatore. Indolente, polemico, edonista gastronomico, ferocemente antijuventino; ama la parmigiana, i giornali di carta, il timorasso, Guccini e Caproni. Un sognatore che non sa dove sta andando, perché c’è già.



























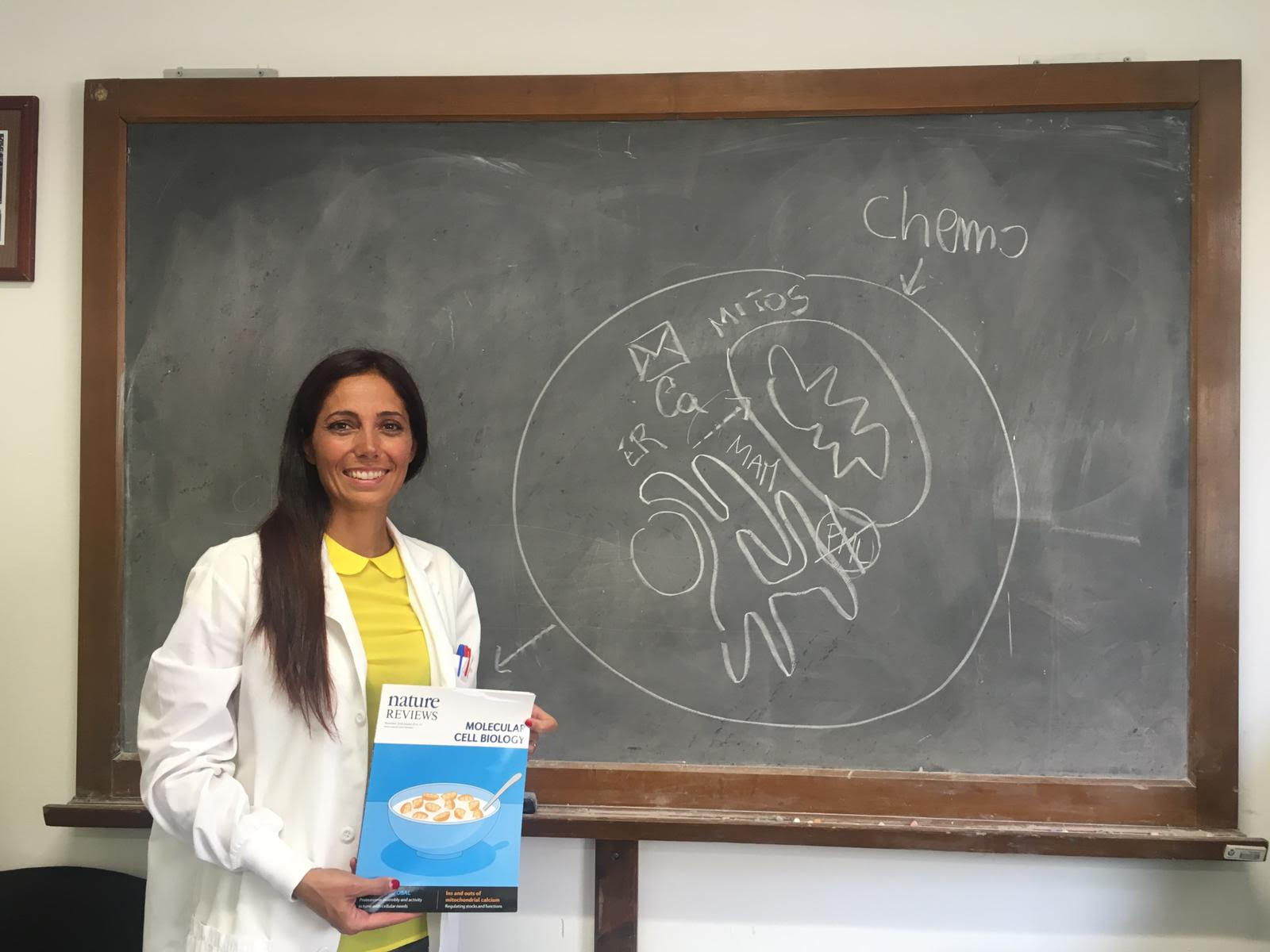


Caro Matteo…posso permettermi visto che ero presente al tuo primo esame importante, alle medie.
Cercando notizie sul nostro attuale assessore alla cultura, ho trovato questo tuo articolo che ho apprezzato molto. Congratulazioni per tutte le cose interessanti che fai e Auguri per i tuoi progetti futuri.
Gloria Pasquesi